Eiderdown, or eider down, comes from the Eider Duck, a large migratory sea duck. Eiderdown is exceptionally soft and has insulating properties superior to any other down. The eiderdown used in luxury duvets and pillows comes from Iceland, in special sanctuaries where the eider ducks can safely rest and nest during their annual migration.
.
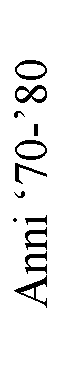
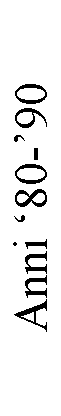
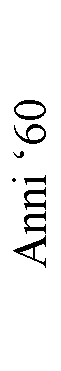
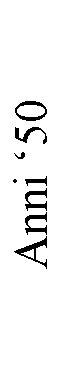
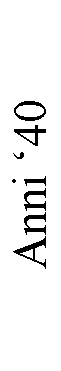
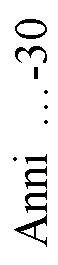
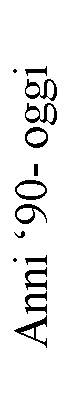
|
Progetto Eiderdown |
|||||||||
|
Periodo |
Information and |
|
Scuole e prospettive |
Autori |
Descrizione |
Film/Romanzi |
Sistemi Informativi |
Riferimenti filosofici |
Riferimenti musicali |
|
|
Intorno al 1810: Scheda perforata 1904 Valvole elettroniche 1905 Calcolatrice elettrica 1914. Calcolatore con numeri in virgola mobile 1932 Memoria basata su relais 1937 Primo centro di calcolo (Londra) Macchina di Turing 1938 Primo calcolatore programmabile dall'utente (Z1) Intorno al 1810: Scheda perforata 1943 Calcolatore Colossus, usato per decifrare codici in ambito militare 1944 Calcolatore Harvard-Mark-I, memoria a tamburo magnetico 1945 Nasce Pankalkul primo linguaggio di programmazione 1946 Principi di Von Neumann per calcolatori universali Primo calcolatore completamente elettronico (ENIAC) 1947 Nascita della prima versione di transistor Calcolatore analogico a elevate prestazioni Basi della teoria dell'informazione 1948 A Manchester il Mark I, primo computer moderno, esegue il primo programma, con una memoria di 96 words, con una velocità di 1 istruzione ogni 1,2 millisecondi 0,00083 MIPS). Seguirà solo nel 1952 l’EDVAC di Von Neumann. 1950 Presentazione del "Test di Turing" 1951 Costruzione in serie del primo calcolatore elettronico prodotto su scala commerciale (Univac I, 5.600 valvole, 18.000 diodi, 19 t di peso, 1 milione di dollari) Avvio delle applicazioni commerciali degli elaboratori 1952 Memoria a nastro magnetico 1953 Costruzione in serie di un grande calcolatore (IBM 701) basato su tecnologia a valvole 1954 Versione perfezionata (e a basso costo) del transistor 1955 TRADIC, primo computer completamente a transistor Linguaggio IPL-II, primo linguaggio per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale 1956 Primo sistema operativo (destinato all'elaboratore IBM 704) Logic Theorist, primo programma basato su tecniche di intelligenza artificiale Utilizzo sperimentale della tastiera per introdurre dati e comandi 1957 Nasce il linguaggio FORTRAN. La prima applicazione ha luogo presso la Westinghouse 1958 Primo circuito integrato 1959 Nasce ERMA, primo sistema di lettura di caratteri magnetici. Il primo utente è la Bank of America 1960 Linguaggio COBOL Nasce Dataphone, primo modem commerciale Costruzione del primo apparecchio Laser Anni '60: sviluppo del primo DBMS (IDS) 1960. Progettazione rete ARPANET Linguaggio COBOL Nasce Dataphone, primo modem commerciale Costruzione del primo apparecchio Laser 1962 Circuito integrato (chip) 1963 Nasce lo standard ASCII, per l'interscambio di dati tra computer 1964 Calcolatore con circuiti integrati Prima applicazione di on-line transaction processing (sistema SABRE di American Airlines) per collegare 2.000 terminali in 65 città Linguaggio BASIC 1965 Dendral, primo sistema esperto sviluppato all'Università di Stanford 1966 L'informatica come disciplina scolastica 1969 Nasce il sistema operativo Unix 1970 Prima legge sulla protezione dei dati Definizione del modello relazionale Primo distributore di contanti presso la Citizens and Southern Bank Realizzazione dei primi 4 nodi di ARPANET 1971 Primo floppy disk da 8 pollici 1972 Nasce 8008, microprocessore a 8 bit Supercomputer (CRAY-1) SmallTalk, primo linguaggio object-oriented 1973 Nasce Ethernet presso il centro di ricerche Xerox di Palo Alto 1974 Primo PC (Mark-8) 1976 Definizione del modello Entità-Relazioni Commutatore ottico 1978 Primo floppy disk da 5 1/4 pollici 1979 Sistema operativo MS-DOS Nascita del linguaggio C++ Visicalc, primo foglio elettronico sviluppato per Apple II 1980 Primo disco ottico 1981 PC IBM WordStar, primo wordprocessor per PC 1982 Nasce il foglio elettronico Lotus 1-2-3 1983 Nasce il word processor Word La CEE dà avvio al programma Esprit per pervenire alla quinta generazione di computer 1985. Introduzione del sistema operativo Windows. Il linguaggio object-oriented C++ diventa uno standard di fatto 1988 Chip di memoria con capacità nell'ordine di megabit 1989 Nasce il concetto di "realtà virtuale" 1990 Sviluppo del linguaggio HTML, del primo web server e del primo browser Creazione WWW presso il CERN di Ginevra Microsoft Windows 3.0 fornisce la prima interfaccia grafica in ambiente PC IBM compatibile. 1991. Calcolatore parallelo 1992. 1995 Internet arriva al grande pubblico 2001 Crollo del nuovo mercato (Enron, Worldcom) 2001 Il processore di Intel per PC supera 1 Ghz 2001 Mobil Oil lancia Mobipass la prima applicazione commerciale di RFID usata per pagamenti contact-less ai distributori. |
1 |
PROSPETTIVA CLASSICA |
|
Teoria che privilegia lo studio degli aspetti formali delle organizzazioni ed enuncia i principi universali di gestione. La corrente delle "relazioni umane" arricchirà l'analisi organizzativa con la scoperta degli aspetti informali; i lavori di analisi comparativa mostreranno i limiti del progetto di enunciazione di principi universali di gestione. |
|
Ad Hoc approach Checkland and Howell provide a nice example of a system with the characteristics of an information system but without the use of computers as components. One of the first information systems whose development has been documented is the early warning system used by the English RAF to defend the southern coast of England from German raids. The information system, which did not make use of computers, was formed by a 1000 human observers placed in holes with observation instruments, 20 of the first radars. Humans and radars reported the observed events (DATA) to the central command in Bentley Priori where mathematicians, military, operations researchers calculated speed and direction of German raiders and referred the attack position (information) to the airfields taking into account both delays and tactics. The methodology used was ad hoc and started from the system goal working backwards to system components, methods and interactions (Checkland P. and Holwell s., 1998, Information, Systems and Information System, Wiley, Chichester (Chapter 5)). Approccio strutturato DeMarco (1979), Yourdon (1989) Obiettivi. Garantire lo sviluppo di software di alta qualità (dal punto di vista dell'affidabilità e della manutenibilità) con una produttività elevata. Concezioni di base. Separazione del modello concettuale dal modello di implementazione. Documentazione accurata per rendere chiaro e visibile il processo di sviluppo. Uso di notazioni grafiche. Modelli di trasformazione e di processo top-down partizionabili. Rappresentazione grafica delle specifiche per ridurre ambiguità e ridondanza. Modelli caratterizzati da alta coesione ed elevata indipendenza logica. Concetti fondamentali. Modello concettuale/modello di implementazione. Trasformazione (processo). Flusso di dati. Archivio dati. Modulo. Coesione. Collegamenti. Principi. Una dettagliata sequenza (passo per passo) delle attività di analisi e progettazione. La "strategia" adottata (modelli a cascata, prototyping, sviluppo concorrente) dipende dalla situazione. Approccio "Information Modeling" Chen (1976), Martin (1989) Obiettivi. Realizzare un sistema informativo e una base di dati estesi all'intera azienda che renda possibile lo sviluppo coordinato di applicazioni integrate e la loro evoluzione di lungo periodo. Concezioni di base. Spiccato orientamento ai dati intesi come elemento base dei sistemi informativi. Separazione di modelli concettuali e modelli/schemi interni. Lo schema concettuale è l'elemento chiave del sistema informativo sulla cui base vengono progettate le applicazioni. Lo sviluppo è basato su una metodologia rigorosa di tipo ingegneristico. Concetti fondamentali. Informazioni/database. Schema concettuale. Schema interno. Schema esterno. Entità. Attributi. Relazioni. Principi. Progettazione incrementale dello schema concettuale. Visione integrata. Approccio "Decision Support Systems" Keen e Scott-Morton (1978), Sprague e Carlsson (1982) Obiettivi. Sviluppare sistemi per supportare attività decisionali parzialmente strutturate. Concezioni di base. Lo scopo di un DSS è supportare anziché sostituire il decisore. il DSS implica interattività, apprendimento ed evoluzione continua. Concetti fondamentali. Decisioni parzialmente strutturate, database, modelli, generatori di DSS. Principi. Sviluppo evolutivo (adattivo). Approccio "Trade Unionist” Bjerknes et al. (1987), Hehn (1988), Bjerknes e Bratteteig (1995 Obiettivi. Creare le condizioni per una partecipazione efficace del lavoratore, al fine di sviluppare la democrazia e la qualità del lavoro. Concezioni di base. Computer come strumenti sotto il controllo del singolo lavoratore. Concetti fondamentali. Sistema tecnico. Sistema sociale. Bisogni tecnici. Bisogni sociali (job satisfaction). Principi. Processi paralleli e indipendenti di accumulazione della conoscenza da parte dei lavoratori. Design by doing, Progettazione partecipata. Approccio orientato agli oggetti Goldberg (1991), Henderson-Sellers e Edwards (1995) Obiettivi. L'approccio orientato agli oggetti nasce per facilitare: il rispetto dei tempi e dei piani di sviluppo, la rispondenza del prodotto finale ai requisiti pianificati, la tempestività delle modifiche rese necessarie da richieste degli utenti o correzioni di errori, l'effettuazione di continue migliorie che garantiscano l'evoluzione e l'adattamento del software ai nuovi standard/esigenze di mercato, il raggiungimento di un elevato grado di coinvolgimento e motivazione del team di sviluppo. Concezioni di base. Analisi, progettazione e implementazione senza soluzione di continuità Concetti fondamentali. Dominio del problema/dominio di implementazione. Oggetto e classe, incapsulamento, ereditarietà, polimorfismo, comunicazione tra oggetti. Principi. Sviluppo iterativo e incrementale, riutilizzo. Approccio Socio-tecnico Mumford (1983), Pava (1983, 86) Obiettivi. Sviluppare sistemi che implichino un ruolo attivo da parte dei futuri utenti fin dalla fase di progettazione. Enfasi sul grado di soddisfazione dell'utente in aggiunta ai requisiti tecnici e operativi, in modo da assicurare "compatibilità organizzativa" al sistema finale. Concezioni di base. Progettazione partecipata. Specifiche tecniche vincolanti ridotte al minimo. Progettazione "aperta". Ricerca della compatibilità tra componente tecnologica (sistema tecnico) e componente umana (sistema sociale). Ottimizzazione congiunta. Concetti fondamentali. Sistema tecnico. Sistema sociale. Bisogni tecnici. Bisogni sociali (job satisfaction). Principi. Partecipazione degli utenti. Progettazione socio-tecnica. Evoluzione Approccio "Soft Systems Methodology" Checkland (1981), Wilson (1984), Checkland e Scholes (1990), Avison e Wood-Harper (1990) Obiettivi. Una metodologia di sviluppo basata sul confronto tra aspettative degli utenti e fattibilità tecnica dei sistemi. Concezioni di base. Utilizzo del concetto di "Human Activity Systems", modelli improntati a diverse concezioni che possono essere applicati a qualsiasi sistema sociale. Il sistema informativo è un sistema che deve supportare lo "human activity system" considerato più appropriato. Concetti fondamentali. Concezione generale (Weltanschauung). Human Activity Systems. Principi. Analisi culturale. Analisi della logica di un sistema. Approccio "Professional Work Practice Mathiassen (1987), Andersen et al. (1990) Obiettivi. Promuovere la crescita professionale dei progettisti dei sistemi informativi. Concezioni di base. La pratica professionale deve guidare l'attività di sviluppo. Le metodologie sono utili ma non possono in alcun modo sostituire l'esperienza. Gli ambiti di sviluppo dei sistemi sono diversi e richiede diverse esperienze professionali. Lo sviluppo efficace dei sistemi richiede di tenere in considerazione due diverse esigenze: performance tecnica e Principi. di management. Concetti fondamentali. Performance/management. Orientamento al prodotto/orientamento al processo. Analisi/progettazione. Pianificazione/valutazione Principi. Le coppie di concetti sopraesposti sono reciprocamente dipendenti e quindi debbono essere applicati contemporaneamente. Approccio “Agile” Beck (1999), Fowler (2002), Lindstrom and Jeffries (2004) Obiettivi: Attempt to provide a useful compromise between no process and too much process, providing just enough process to gain a reasonable payoff (Fowler M.). Creare sistemi informativi intrinsecamente validi. Fornire frequentemente moduli funzionali agli utilizzatori. Concezioni di base: Agile methods are adaptive rather than predictive. Agile methods are people-oriented rather than process-oriented (people refers to programmers not to users). About requirements: not just are requirements changeable, they ought to be changeable. Accelerare al massimo il tempo di sviluppo. La chiave per creare sistemi informativi utili per il cliente risiede nell’attaccare sub-problemi ben delimitati risolvibili nel giro di poche settimane. La conoscenza di utilizzatori e sviluppatori e’ imprescindibile dalla pratica. Il test di piccole parti del sistema in condizioni di uso quotidiano e’ l’unico garante della validità della soluzione proposta. Concetti fondamentali: Orientamento al cliente. Dei tre parametri utilizzati nella definizione di progetti di sviluppo: tempo, funzionalità, costo, solo due si possono fissare mentre il terzo deve poter variare (di solito le funzionalità). Principi: Test before coding, refactoring, paired programming, user on location, user testing The Bazaar “a chaotic structure” A metaphor for agile methodologies |
Rationalism (Leibnizian Philosophy) Reality exists and is the same for every individual. Reality can be objectively described. What happens in reality is governed by laws of causality. Within this philosophy the inquirer discovers through formal logic the truth governing the world. The system under study is considered as closed and governed by causal relationships. The inquirer creates networks of hypotheses, fact nets, and proceeds to build on these hypotheses until logic reveals a counterhypothesis that invalidates a part of the net. The Leibnizian inquirer is the isolated individual, the monad (Churchman 1971, p. 30), reasoning on the causal relationships governing the system that he wants to improve. The individual’s logic becomes the guarantor of the truthfulness of the fact net. Rationalism and ISD methodologies: The point of departure is that there exist a solution for each problem which is optimal. This is the solution we have to achieve or try to. Optimal requirements for an information system can be found using reason. Pure structured methodologies (Eg. Waterfall, Information Engineering and “linear” methodologies in general) are built on the ideas of the Leibnizian philosophy: once requirements are specified the programmer proceeds on his own to develop the information system based on his internal logical reasoning. The software will therefore reflect the fact nets developed by the inquirer (i.e. the programmer). Rational behind this choice: Because the hypotheses is made that there is only one truth governed by cause and effect than it is perfectly justifiable to separate the development in sub-activities carried out by different parties. The choice is also highly culturally determined as the Rationalist philosophy is very rooted in western culture and well suited to research the domain of natural sciences. First educated computer scientists were coming from mathematics. He image of the cathedral, used later by Raymond as a metaphor for structured methodologies is well connected to Leibnitz philosophy whose ultimate goal was to prove the existence of God. Empiricism (Lockean Philosophy) Reality exists and is the same for every individual. Reality can be objectively described. What happens in reality is governed by laws of causality. The individual has no preconception of reality and all input come from the outside. This mode of inquiry gives more weight to data than theory. The inquirer is open to the environment and finds the truth in the external world. The inquirer is not isolated like the monad but participates in creating knowledge with a community of inquirers, the Lockean community. The inquirer uses data and the opinion of his community to explain the world. The community acts guarantor of the truth through agreement and consensus. The Lockean inquiring system searches a single truth but there is no guarantee that two communities will agree on a common truth. If there is a winning or prevailing community this is often the result of power unbalance. Empiricism and ISD methodologies: In ISD, the groups of users and developers can be considered as two Lockean communities, where agreement can be found within a community but it is difficult to find it across communities. The trade unionist approach is partially based on the idea of different communities having to agree on the solution provided by the information system. Phased and linear development process is acceptable since the goals for any phase can be specified a priori. Rational behind this choice: Because the hypotheses is made that there is only one truth governed by cause and effect than it is perfectly justifiable to separate the development in sub-activities carried out by different parties. The choice is also highly culturally determined as the Rationalist philosophy is very rooted in western culture and well suited to research the domain of natural sciences. First educated computer scientists were coming from mathematics. Idealism (Kantian Philosophy) This mode of inquiry gives equal weight to data and theory. It recognizes that there are multiple ways in which a problem may be analyzed using multiple models that can be applied to the data. However the inquirer does not accept multiple truths; the objective is to find the ideal, and only, truth. The Kantian inquirer proceeds testing the fitness of a model to the data and creates knowledge by finding the model that best fits the data. Kant and ISD methodologies: There is not a clear cut connection between ISD methodologies and Kant’s philosophical precepts. In ISD it can be imagined that the Kantian inquiring system is used when developers search a model to mirror the client system into the software system. Many possibilities are tried and recursively eliminated until only one, the one with the best fit, the truth, remains. Dialectic (Hegelian Philosophy) This philosophical approach sees the truth emerging the debate between opposing views: the thesis and the antithesis. Debate between different worldviews (Churchman, 1968; Linstone, 1984; Orlikowski, 1992) is seen as the only way to develop theses and antitheses to arrive at a synthesis that accommodates both worldviews. Hegel introduces the idea of multiple interpretations of reality even though he believed in a final “grand synthesis”. Churchman (1968) envisioned two groups of people engaged in an ardent debate respectively defending their thesis and trying to destroy the other group’s antithesis. The issue is then resolved by an impartial observer that synthesizes the arguments to create a synthesis. Synthesis generated from the impartial observer acts as the guarantor of the truth (Courtney, Croasdell, and Paradice, 1998). A good example of this inquiring system is the scenario approach at Shell where groups with opposing views engaged in a dialectic inquiry and predicted the oil crisis in 1973 (Shoemaker, 1995; Senge, 1990 p. 178). Dialectic and ISD methodologies: The point of departure is that the grand solution - if it can be found—can only emerge from the ardent dabate. The process cannot be leaner because the nature of the debate is not linear nor it is known the nature of the synthesis. The synthesis could be a quantum leap with respect to the pre-exiting knowledge. The socio-technical approach where the system emerges from the two worldviews of the social and the technical system is based on the idea of dialectic inquiry. The Soft system methodology approach is a derivate of the socio-technical one but it is more modern and more detailed (and therefore more structured). In the SSM approach the two weltanschauung (that shape thesis and antithesis) are represented but the human activity system (the served system) and the technical system (the serving system). Rational behind the choice: the Hegelian process of creating knowledge is indicated to attach complex problems where the solution is not clear at the offset. These problems are known as ill-structured. In this cases the debate helps to reach an agreement on the solution.. Pragmatism (Singerian Philosophy). Singer was particularly interested in the creation and exchange of knowledge. Singer philosophy was at the base of Churchman’s work (1971) on the design of the inquiring systems. The Singerian inquiring system is based on the ardent debate of the Hegelian philosophy to create progress but accepts multiple sources of data and multiple interpretations of reality and consequently multiple truths. It is called pragmatic inquiring system because the truth/s produced is/are relative to the context and to the objectives of the inquiry. The multiple truths are found via an approach that continuously attacks currently held beliefs from multiple points of view. The world inquired is interpreted as an open system where all components might become part of the inquiry. The truth is temporary and contextually dependent because the more elements are “swept in” (Courtney et al., 1998) the more the truth is likely to change. Progress is the ultimate goal of the system and it is measured quantitatively whenever possible otherwise the groups’ intuition that progress is made becomes the guarantor for qualitative measures (Richardson et al., 2001). Pragmatism and ISD methodologies: In ISD the use of the Singerian inquirer can be recognized in recent methodologies like the ones coming from Soft Systems Methodology (Atkinson, 2000; Winter et al., 1995), Multiview2 (Avison et al. 1998) and in agile methodologies (Beck, 1999; Fowler, 2002). The testing carried out using agile methodologies is completely in line with the pragmatic nature of the knowledge needed to be exchanged during the ISD process. Richardson and Courtney (2004) propose a design theory for knowledge management systems based specifically on the Singerian inquiry. These methodologies let the information system emerge from the debate between developers and users letting multiple truths be created pragmatically by the participants and not imposed top-down. Rational behind the choice: in today’s world the only software that is developed ad hoc is specialized software that respond to a very specific need (otherwise it is more convenient to buy and customize) consequently the problematic involved present very complex knowledge dynamics that can be tackled with the Singerian concepts of debate, sweep-in, knowledge exchange based on practice. |
1911 ♪ Schönberg, Sechs kleine Klavierstücke op. 19 ♪ Schönberg’s paintings in the art exibitions of Kandinsky and Marc’s « Der blaue Reiter » Association ♪ Schönberg, Herzgewächse, on a text by Maurice Maeterlinck, published in facsimile in the « Jahrbuch » (Almanach) of « Der blaue Reiter » Association ♪ Schönberg writes his contribution to the « Jahrbuch » (Almanach) of « Der blaue Reiter » : The Relationship with the Text ♪ Schönberg, Harmonielehre (first edition) ♪ Maurice Ravel, L’heure espagnole ♪ Jean Sibelius, Symphony no. 4 ♪ Igor Stravinsky, Petrushka ♪ Richard Strauss, Der Rosenkavalier ♪ Alexander Skrjabin, Prometheus 1912 ♪ Arnold Schönberg, Pierrot lunaire ♪ The European tournée, conducted by the composer with the so called Pierrot Ensemble, is a big success ♪ Alban Berg, Fünf Orchester-Lieder nach Ansichtskartentexte von Peter Altenberg op. 4 ♪ Franz Schreker, Der ferne Klang 1913 ♪ First performance of Schönberg’s Gurrelieder (Vienna, Franz Schreker conductor) ♪ Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps (first performance with the Djagilev’s « ballets russes », Paris) ♪ Claude Debussy, Jeux 1914 ♪ Erik Satie, Sports et Divertissements ♪ Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps (first performance without coreography in Moscow and Paris) ♪ Alban Berg, Drei Orchesterstücke op. 6 1915 ♪ Schönberg starts writing the text of his (unfinished) oratorio Die Jakobsleiter 1916 ♪ Richard Strauss, Ariadne auf Naxos 1917 ♪ Igor Stravinsky, Les noces and Renard 1918 ♪ « Verein für musikalische Privataufführungen » (Association for private musical performances) : the first series of private concerts arranged and performed in Vienna by Schönberg and his circle (until 1922) ♪ Igor Stravinsky , Histoire du Soldat 1919 ♪ Richard Strauss, Die Frau ohne Schatten 1920 ♪ Igor Stravinsky, Pulcinella ♪ Erik Satie, Socrate 1921 Schönberg tells to some of his students about his new idea of a « method of composing with twelve tones » Schönberg becomes aware of his being a Jew (the so called « Mattsee Episode » 1922 ♪ Jean Sibelius, Scaramouche 1923 First Festival of ISCM (International Society for Contemporary Music) in Salzburg ♪ Edgard Varèse, Hyperprism ♪ Arthur Honegger, Pacific 231 ♪ Alexander von Zemlinsky, Lyrische Sinfonie 1924 ♪ Berg: Drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck first performed by Heinrich Scherchen at the Frankfurt Festival of the ISCM. On that occasion Theodor Wiesengrund Adorno meets Alban Berg,and decides to go to Vienna to study composition with him ♪ Edgar Varèse, Octandre 1925 Schönberg is called to teach the master class in composition at the Akademie der Künste, Berlin (he held this position until 1933) ♪ Alban Berg, Wozzeck ♪ Arnold Schönberg, Drei Satiren op. 28 1926 ♪ Edgard Varèse, Amériques ♪ Kurt Weill, Der Protagonist ♪ Paul Hindemith, Cardillac 1927 ♪ Bela Bartók, Piano Concerto no. 1 ♪ Sergej Rachmaninov, Piano Concerto no.4 The Automatic Instrument Company (AMI) introduces the selective phonoghraph (jukebox) 1928 ♪ Arnold Schönberg, Variationen für Orchester op. 31 ♪ Igor Stravinsky, Oedipus Rex ♪ Anton Webern, Sinfonie op. 21 ♪ Maurice Ravel, Bolero ♪ Bertolt Brecht/Kurt Weill, Die Dreigroschenoper 1930 ♪ Arnold Schönberg, Von heute auf morgen ♪ Dmitri Shostakovic, Symphony no. 3 ♪ Kurt Weill, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny 1932 ♪ Schönberg ends the composition of the second act of his (unfinished) three-acts opera Moses und Aron 1934 ♪ Arnold Schönberg, Suite für Streichquartett ♪ Paul Hindemith, Mathis der Maler ♪ Anton Webern, Konzert für neun Instrumente op. 24 ♪ Alban Berg, Sinfonische Stücke aus der Oper Lulu ♪ Igor Stravinsky, Persephone 1935 ♪ Richard Strauss, Die schweigsame Frau ♪ George Gershwin, Porgy and Bess ♪ Anton Webern, Das Augenlicht op. 26 1936 ♪ Béla Bartok, Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta 1937 ♪ Benjamin Britten, Variations sur un thème de Frank Bridge 1938 ♪ Arnold Schönberg, Kol Nidre 1939 ♪ Kuigi Dallapiccola, Volo di notte 1940 ♪ Anton Webern, Variationen für Orchster op. 30 1942 ♪ Arnold Schönberg, Ode to Napoleon op. 41 1946 ♪ Arnold Schönberg, String Trio op. 45 Beginning of Ferienkurse für Neue Musik (International Summer Courses in New Music) in Darmstadt, Schoenberg is named honorary president ♪ Bela Bartók, Piano Concerto no. 3 ♪ Benjamin Britten, The rape of Lucretia ♪ Richard Strauss, Metamorphosen 1947 ♪ Arnold Schoenberg, A survivor from Warsaw op. 46 ♪ John Cage, The Seasons ♪ Kurt Weill, Street Scene Atlantic Records founded by Ahmet and Nesuhi Ertegun 1948 ♪ Olivier Messiaen, Turangalila ♪ Pierre Boulez, Second Piano Sonata ♪ John Cage, Sonatas and Interludes ♪ Luigi Dallapiccola, Il prigioniero ♪ Goffredo Petrassi, Il cordovano Columbia begins marketing the 33rpm LP 1949 ♪ Arnold Schönberg, Fantasy for Violin and Piano, op. 47 ♪ Giorgio Federico Ghedini, Billy Budd The first Congress of Dodecaphonic Music is held in Milan RCA introduces the 45 rpm disc. 1950 Foundation of the Electronic Music Studio at Westdeutscher Rundfunk in Köln ♪ Pierre Schaeffer: Symphomie pour un homme seul (first extended piece of electronic music) ♪ Luigi Nono, Variazioni canoniche su una serie dell’op. 41 di Schönberg ♪ Goffredo Petrassi, Noche oscura 1951 ♪ Pierre Boulez, Terza Sonata ♪ Francis Poulenc, Stabat Mater ♪ Igor Stravinsky, The Rake’s Progress ♪ John Cage, Music of Changes ♪ Karlheinz Stockhausen, Kreuzspiel Stefan Kudelski builds the first Nagra portable, self contained tape recorder 1952 Otto Luening and Vladimir Ussachevsky present the first american concert of electronic music at MOMA, N.Y. ♪ John Cage, Imaginary Landscape n. 5 ♪ Karel Goeyvaerts, Composition n. 4 aux sons morts ♪ Bruno Maderna, Musica su due dimensioni 1954 Boulez founds the Domaine Musical in Paris, dedicated to the promotion and performance of contemporary music ♪ Luigi Nono, La victoire de Guernica ♪ Igor Stravinsky, Septet, In memoriam Dylan Thomas 1955 Foundation of the “Studio di Fonologia” at RAI in Milano ♪ Serge Prokofiev, War and Peace ♪ Igor Stravinsky, Canticum sacrum Invention of the RCA Electronic Music Synthesizer 1956 ♪ Karlheinz Stockhausen, Gesang der Jünglinge ♪ Glenn Gould, recording of Bach’s Goldberg Variations ♪ Luigi Nono, Il canto sospeso ♪ Louis and Bebe Barron produce the first electronic music for a commercial film, Forbidden Planet 1957 ♪ Karlheinz Stockhausen, Gruppen ♪ Igor Stravinsky, Agon 1958 ♪ Luciano Berio, Sequenza I ♪ Max Mathews, of Bell Laboratories, generates music by computers 1959 ♪ Sylvano Bussotti, Five piano pieces for David Tudor 1960 ♪ Bernd Alois Zimmermann, Die Soldaten ♪ Gyorgy Ligeti, Apparitions Recording studios begin using multitrack tape machines 1961 ♪ Luigi Nono, Intolleranza 1960 ♪ Krzysztof Penderecki, Threnody for the victims of Hiroshima ♪ Elliott Carter, Doppio concerto 1962 First Issue of the Journal Perpectives of new music ♪ Gyorgy Ligeti, Aventures ♪ Franco Evangelisti, Die Schachtel ♪ Mauricio Kagel, Antithese ♪ Igor Stravinsky, The Flood 1964 ♪ Bruno Maderna, Hyperion ♪ Luigi Nono, La fabbrica illuminata 1965 ♪ Sylvano Bussotti, La Passion selon Sade 1966 ♪ Terry Riley, In C ♪ Iannis Xenakis, Terretektorh 1967 ♪ Karlheinz Stockhausen, Hymnen ♪ Gyorgy Ligeti, Cello concerto, Lontano Invention of Dolby noise-reduction system for use in tape-recording 1968 ♪ Luciano Berio, Sinfonia ♪ Luigi Dallapiccola, Ulisse 1970 ♪ Sylvano Bussotti, Rara Requiem ♪ Karlheinz Stockhausen, Mantra ♪ Philip Glass, Music in fifths 1972 ♪ Bruno Maderna, Aura ♪ Sylvano Bussotti, Lorenzaccio Issue of the first LP made from digital masters 1973 ♪ Gérard Grisey, Dérives 1975 ♪ Luigi Nono, Al gran sole carico d’amore ♪ Iannis Xenakis, Empreintes 1976 ♪ Luciano Berio, Coro ♪ Elliott Carter, A Mirror on Which to Dwell ♪ Philip Glass, Einstein on the beach 1977 ♪ Arvo Pärt, Fratres, Cantus In Memoriam Benjamin Britten, Tabula Rasa ♪ Opening of Centre Georges Pompidou in Paris and opening of IRCAM, directed by Pierre Boulez 1978 ♪ Gyorgy Ligeti, Le Grand Macabre 1979 ♪ John Cage, Roaratorio Sony introduces the first “walkman” portable cassette player 1980 ♪ Brian Ferneyhough, Funérailles ♪ Salvatore Sciarrino, Les cailles en sarcophage 1981 ♪ Karlheinz Stockhausen, Donnerstag aus “Licht” ♪ Pierre Boulez, Répons ♪ Salvatore Sciarrino, Vanitas Sony introduces the CPD-101, the first Compact Disc audio CD player 1982 ♪ Luciano Berio, La vera storia ♪ Philip Glass, Glassworks ♪ Philips introduces the first digital audio 5 -inch disc 1983 ♪ Salvatore Sciarrino, Lohengrin Standard MIDI (Musical Instruments Digital Interface) 1984 Foundation of the Journal Contemporary Music Review ♪ Luigi Nono, Prometeo ♪ Franco Donatoni, Atem 1986 ♪ Sofija Gubajdulina, Stimmen… Verstummen ♪ Franco Donatoni, In cauda 1987 ♪ Adriano Guarnieri, Il trionfo della notte First DAT (digital audio tape) machines appear on the market 1988 ♪ Gérard Grisey, Le temps et l’écume ♪ Helmut Lachenmann, Gran Torso 1990 ♪ Iannis Xenakis, Tetora Sony introduces the writeable CD 1991 ♪ Stefano Gervasoni, Least Bee on poems by Emily Dickinson 1992 ♪ Gérard Grisey, L’icone paradoxale (Hommage à Piero della Francesca) ♪ Wolfgang Rihm, Gesungene Zeit 1993 ♪ Steve Reich, The Cave 1996 ♪ Thomas Adès, The Premises are Alarmed 1998 Founding of the mp3.com website 2000 Prometeo by Luigi Nono is first performed in Milan after Nono’s death: more than 100 Italian intellectuals sign an appeal against the critic of “Corriere della Sera” because of his misunderstanding of the work (among them Claudio Ciborra) 2001 ♪ Stefano Gervasoni, Chhamp for orchestra 2002 ♪ Adriano Guarnieri, Medea ♪ Salvatore Sciarrino, Macbeth |
|
1.1 |
Organizzazione scientifica del lavoro |
Taylor (1895, 1903, 1911) |
Il modello organizzativo proposto da Taylor si caratterizza per una divisione del lavoro chiaramente definita e per la presenza di una forte gerarchia che assicura il coordinamento dei diversi compiti. Essenza del nuovo sistema di gestione e direzione: 1) Sviluppo di conoscenze su basi scientifiche; 2) Selezione scientifica della manodopera; 3) preparazione e perfezionamento dei lavoratori su basi scientifiche; 4) intima e cordiale collaborazione fra dirigenti e manodopera. Le critiche al Taylorismo si focalizzano principalmente sull’organizzazione scientifica come soluzione organizzativa, con particolare riferimento alla rigidità e ai problemi legati all’apprendimento. Tra le principali critiche emergono: mancanza della considerazione sociale del lavoro, orientamento all’autoritarismo, uomo come “macchina”. |
Film: "Tempi moderni", Chaplin (1936) Scena “catena montaggio” (57sec) · Parcellizzazione estrema lavoro · Controllo e trattamento disumano · Uomo-macchina La classe operaia va in paradiso" Romanzi: “Tempi difficili” Dickens(1854) |
|||||
|
1.2 |
Scuola dei principi di amministrazione |
Fayol (1916), Mooney (1937) Mooney e Reiley (1939), Gulick e Urwick (1937) |
La scuola dei principi di amministrazione si focalizza sullo studio delle funzioni manageriali e dei principi per il loro funzionamento. Fayol si interessa principalmente allo studio della funzione direzionale, in quanto presenta contenuti specifici non inseribili in alcuna delle altre funzioni (es. funzione tecnica, commerciale, finanziaria…). Secondo Fayol, ciascuna funzione richiede delle capacità specifiche. In particolare, le capacità direzionali sono riconducibili a: pianificazione, organizzazione, comando, coordinamento, controllo. La funzione direzionale presenta due peculiarità: 1) Universalità: le 5 capacità direzionali sono indipendenti dal tipo di organizzazione. 2) Pervasività: le capacità della funzione direzionale non caratterizzano solo il vertice, ma tutta l’organizzazione (in misura diversa in base a livello gearchico, dimensioni,…) Le capacità direzionali sono migliorabili sia attraverso la pratica, sia attraverso l’insegnamento formale (cfr. differenza con Taylor). |
|
|||||
|
1.3 |
Teoria della burocrazia |
Weber (1922) (trad. ing. 1947) |
La teoria burocratica prende in considerazione le problematiche relative alle forme di influenza del comportamento altrui. Secondo Weber, l’esercizio dell’autorità su una molteplicità di persone richiede un’organizzazione, ed il tipo più puro di esercizio legale dell’autorità si avvale di una configurazione organizzativa burocratica. La burocrazia rappresenta quindi una configurazione "ideale" di organizzazione. La burocrazia si caratterizza per una ben definita gerarchia dell'autorità, per la specializzazione dei compiti, per un funzionamento basato su regole e procedure formali, e per l’impersonalità delle relazioni tra attori organizzativi. L'obiettivo è quello di garantire sia l'efficienza nell'esecuzione dei compiti sia l'equità nel trattamento del personale e degli utenti. I lavori di analisi comparativa mostrano che queste modalità di gestione possono valere anche al di fuori delle organizzazioni pubbliche e che esistono nella realtà più forme di burocrazia. Le conseguenze inattese di questo tipo di organizzazione, come l'alienazione degli attori, la trasposizione fini-mezzi, l'apatia, la rigidità di funzionamento, hanno ricevuto una grande attenzione (vedi Airoldi pag. 15: Merton, Selznick, Etzioni, fino a Crozier. Vedi anche manuale 1-20: Parson, Gouldner, Blau, Scott). |
|
|||||
|
2 |
SCUOLA BEHAVIORISTA |
|
Questo movimento nasce intorno agli anni 30 da due filoni di ricerca principali: l'opera di Chester Barnard e i cosiddetti esperimenti di Hawtorn. L'opera di Barnard "The Functions of the Executive" ha costituito uno dei primi tentativi sistematici di elaborare una teoria dell'organizzazione che ha avuto una grande influenza sia sul pensiero behaviorista, sia sulle concezioni istituzionaliste di Selznick e sulla teoria delle decisioni di Simon. Gli esperimenti di Hawthorne furono condotti in uno stabilimento della Western Electric Co da Roethlisberger e Dickson e successivamente analizzati ed interpretati da Mayo. In opposizione all'orientamento essenzialmente strutturale della teoria classica, la scuola behaviorista sviluppa una diversa visione, incentrata sulla natura umana e sul comportamento degli attori nelle organizzazioni. Non si tratta di ignorare la struttura organizzativa ma di mettere in luce come sia modellata dai bisogni, dalle capacità, dai limiti degli individui e in quale misura essa influenza i loro comportamenti. Questi approcci comportamentali si focalizzano sull'analisi dei processi di funzionamento delle organizzazioni. Esistono tuttavia differenze significative all’interno della scuola behaviorista relativamente alle variabili oggetto di analisi, nonché all’approccio di ricerca. La corrente delle relazioni e delle risorse presenta un orientamento normativo, mentre i teorici della scuola Carnegie hanno assunto un approccio più descrittivo. |
|
|||||
|
2.1 |
Movimento delle "relazioni umane" |
Barnard (1938), Roethlisberger e Dickson (1939), Mayo (1933,45) |
Raggruppa più ambiti di ricerca con obiettivi omogenei: lo studio del funzionamento dei gruppi di lavoro, quello dei fenomeni informali nelle organizzazioni, la questione degli stili di supervisione. Nell'insieme il movimento delle relazioni umane mette in evidenza l'importanza del fattore umano nelle organizzazioni e la necessità di considerare i bisogni sociali e di stima degli individui per accrescere la produttività. I bisogni sociali degli individui mettono in luce l’esistenza di una personalità individuale e organizzativa dell’individuo, evidenziando l’importanza dell’equilibrio tra contributi verso l’organizzazione e benefici ricevuti. La criticità del fattore umano richiede un ripensamento degli stili manageriali rispetto alle teorie classiche. Infatti, emerge la necessità di un management orientato alla collaborazione, all’ascolto e all’empowrment. I limiti di questo movimento consistono in una visione incompleta dei bisogni e dei comportamenti degli individui, una certa ingenuità nell'interpretazione dei conflitti e la preconizzazione di pratiche di gestione che possono degenerare in manipolazione. |
|
|||||
|
2.2 |
Corrente "Carnegie" (o delle decisioni) |
Simon (1947, 1957), March e Simon (1958), Cyert e March (1963) |
I teorici della corrente Carnegie, i cui primi lavori risalgono alla fine degli anni ‘40, esplorano le conseguenze organizzative delle capacità limitate dell'individuo in termini di trattamento dell'informazione e di risoluzione dei problemi. I loro contributi alla comprensione dei processi decisionali nell'organizzazione sono fondamentali. Si deve loro la nozione di razionalità limitata, la nozione di apprendimento organizzativo, e la visione dell'organizzazione come coalizione mutevole di interessi molteplici e conflittuali che i principali decisori cercano di soddisfare in modo sequenziale (nozione della quasi-risoluzione dei conflitti). Mentre nelle due correnti precedenti la variabile organizzativa sulla quale è posta una maggiore importanza è il clima organizzativo, con la corrente Carnegie l'enfasi è posta prevalentemente sul modo in cui il comportamento degli individui è programmato da procedure operative ed euristiche, sugli aspetti politici del funzionamento delle organizzazioni e sui processi decisionali. La corrente Carnegie si avvale anche degli apporti della matematica applicata e della ricerca operativa e fa riferimento, per la prima volta in modo sistematico, all'utilizzo di strumenti automatici per il trattamento dell'informazione e per il supporto alle decisioni. Un aspetto fortemente innovativo è la focalizzazione su due specifiche componenti della dinamica organizzativa: l'informazione e la decisione. |
Film: "2001 Odissea nello spazio", Kubrick (1968) "Guerre Stellari" Lucas (1977) (tema del mito degli automi intelligenti) |
|||||
|
2.3 |
Corrente delle "risorse umane" (o nuove relazioni umane) |
Argyris (1957, 1962), Herzberg, Mausner e Snyderman (1959), McGregor (1960), Likert(1961), Herzberg (1966) |
Come il movimento delle relazioni umane, così anche la corrente delle risorse umane, che nasce verso la metà degli anni 50, dà molta importanza alla questione della motivazione degli individui, ma più che i bisogni sociali e di stima sono i bisogni di realizzazione di sé, di attuazione del proprio potenziale che sono considerati come fondamentali. Si tratta di mettere in atto forme organizzative che permettano agli individui di esprimere il proprio potenziale. Tali forme, essenzialmente partecipative, si contrappongono ai principi classici e burocratici dell'organizzazione, considerati come fonte di frustrazione degli individui e di spreco dei loro talenti. I principali contributi di questa corrente portano alla gestione del cambiamento, alla gestione dei conflitti e alle pratiche di sviluppo delle risorse umane. Questa corrente condivide con il movimento delle relazioni umane una certa ingenuità nell'interpretazione dei conflitti e una sopravvalutazione delle questioni della motivazione a spese di quelle relative alle proprietà cognitive degli individui. Come nelle teorie classiche, si cede alla tentazione di proporre principi di portata universale. |
Film: "A tempo pieno", Cantet (2001), scena del protagonista che dorme in macchina (tema delle motivazioni — scala di Maslow) |
|||||
|
3 |
SCUOLA FUNZIONALISTA |
Parsons (1951), Merton et al. (1952), Merton(1957) |
Il funzionalismo affonda le sue radici nei lavori di Comte, Spencer, Pareto e Durkheim. Parsons ha sviluppato un modello generale adatto all'analisi di ogni tipo di collettività, dai piccoli gruppi primari alle intere società. Gli studi di Parsons definiscono le quattro funzioni fondamentali che tutti i sistemi sociali devono svolgere per sopravvivere, individuate dalla sigla AGIL (Adaptation, Goal, Integration, Latency). Adaptation: il problema di raccogliere risorse sufficienti. Goal: il problema della definizione e del raggiungimento degli obiettivi. Integration: il problema del coordinamento tra le sottounità del sistema. Latency: il problema del creare, conservare e trasmettere la cultura specifica e i valori del sistema. Il modello AGIL può essere applicato per stabilire un collegamento funzionale tra le organizzazioni e la società (livello ecologico); a livello di analisi strutturale, invece, esso definisce i sottosistemi differenziati che ogni organizzazione deve sviluppare per far fronte alle quattro esigenze fondamentali. Gli studi di Merton si concentrano inizialmente sull'analisi degli aspetti di degenerazione del tipo ideale di burocrazia descitto da Weber, che fu tradotto in inglese alla fine degli anni '40. In particolare è noto nella letteratura organizzativa per la descrizione delle disfunzioni burocratiche e del fenomeno della trasposizione fini-mezzi. Merton riesce a chiarire e a rimettere a punto alcuni aspetti fondamentali della teoria funzionalista. I più importanti sono: l'accento sulle disfunzioni, la distinzione tra funzioni manifeste e latenti, il concetto di alternativa funzionale e l'insistenza sull'importanza di scoprire e comprendere i meccanismi che assolvono a determinate funzioni. Tuttavia Merton abbandona la ricerca di una teoria omnicomprensiva (tipica dell'approccio funzionale) per assumere una prospettiva definita "teoria di medio raggio". Essa è caratterizzata da una serie limitata di presupposti da cui si possono derivare e verificare empiricamente delle ipotesi specifiche. Durkheim, Parsons e Merton considerano l’agire umano come predeterminato, funzione di forze sottostanti, di bisogni, di norme, di valori interiorizzati , caratteristici di ogni società. Tutti gli studiosi funzionalisti considerano il comportamento umano determinato in partenza e, quindi, in linea di principio, pienamente esplicabile |
Degenerazione della burocrazia e trasposizione fini-mezzi Film: "Un giorno di ordinaria follia", Schumacher (1993) · Sorriso innaturale, uso del nome: confidenza di facciata · Richiesta respinta: rispetto cieco delle regole Film: “Le dodici fatiche di Asterix”, Goscinny-Uderzo (1975) · Incapacità di ascolto, modi sgarbati · Indicazioni errate · Disinteresse personale · Trasferimento responsabilità · Eccesso di procedure formali · Il meccanismo si inceppa · Troppe regole = nessuna regola Romanzi: “Tutti i nomi” Saramago (1998) (crisi/cambiamento nella burocrazia) |
|||||
|
4 |
SCUOLA ISTITUZIONALE |
Selznick (1949, 1957) Perrow (1961) |
Secondo Selznick, che ha avuto Perrow come allievo, "La cosa più importante per le organizzazioni è che, sebbene siano degli strumenti, nondimeno ciascuna ha una vita sua propria" (Selznick, 1949, trad. it. 1974, pag. 25). Selznick designa il processo attraverso il quale un'organizzazione sviluppa un suo particolare carattere come "istituzionalizzazione". Per questo autore, istituzionalizzato significa "infuso di valore al di là delle esigenze tecniche del compito immediato" (1957, pag. 24 nella trad. it. del 1976). A Selznick si deve il concetto di “competenza distintiva”, coniato nel 1957. |
Film: "Lanterne rosse", Yimou (1991) "Una poltrona per due", Landis (1983) "Il fascino discreto della borgesia", Bunuel (1972) "Philadelphia" Demme (1993) (tema del condizionamento sociale e istituzionale) Romanzi: "La macchia umana", Roth(2000) |
|||||
|
5 |
TEORIE SISTEMICHE |
Beer (1964), Haberstroh (1965), Katz e Kahn(1966) |
L'approccio sistemico, che si ispira alla Gestalt Theorie, vede l'organizzazione come un tutto inserito in un ambiente con il quale intrattiene relazioni di input/output di energia. Questo insieme è scomponibile in sottoinsiemi, ma sono le relazioni tra questi che sono essenziali per comprendere il funzionamento del tutto (che non è determinato dalla somma delle parti). L'approccio sistemico apporta numerosi contributi agli studi di organizzazione: l'enunciazione degli attributi e delle proprietà dei sistemi aperti verso un ambiente esterno (ciclo di trasformazione dell'energia, nozioni di entropia, omeostasi, differenziazione, equifinalità); l'identificazione dei componenti di un sistema, l'analisi delle loro interazioni, l'analisi delle forze che modellano un sistema, etc. Questa scuola ha fornito contributi descrittivi, che offono un apporto alla conoscenza del funzionamento delle organizzazioni, ed anche prescrittivi, con delle formulazioni che si iscrivono nella concezione cibernetica, ispirata alla scienza dei meccanismi autoregolati. Tra questi gli studi di Haberstroh hanno definito per la prima volta il concetto di scatola nera. |
|
|||||
|
5.1 |
Teoria delle contingenze strutturali |
Burns e Stalker (1961), Woodward (1965), Lawrence e Lorsch(1967), gruppo di Aston (Pugh, Hinings, Hickson), Child (1972) Galbraith (1973, 1977), Mintzberg (1979, 1983) |
Il cuore delle teorie contingenti è rappresentato dall’abbandono di un approccio universalista per la progettazione dell’organizzazione. I teorici della contingenza affermano, infatti, che la configurazione dell’assetto organizzativo debba essere declinata in funzione del contesto di riferimento. Secondo queste scuole, le variabili di contesto o di situazione impongono dei vincoli organizzativi ai quali è necessario conformarsi. Le scuole contingenti hanno avuto ed hanno tuttora un impatto importante sulla teoria organizzativa. Le principali variabili di contesto considerate dai teorici della contingenza sono: tecnologia, dimensioni, ambiente, e strategia. Galbraith cerca di sviluppare una visione che integri i quattro elementi del contesto basandosi sulla “predicibilità dei compiti”. Secondo l’approccio di Galbraith, la configurazione organizzativa è influenzata dalla complessità informativa che il contesto richiede (in termini di incertezza, interdipendenza e numerosità). Un’altra prospettiva orientata alla sintesi è stata offerta da Mintzberg, il quale prevede la necessità di una coerenza tra ambiente e struttura, e tra elementi costituenti il sistema organizzativo. La visione di Mintzberg rappresenta il primo passo verso una critica alla forte matrice determinista delle teorie contingenti. Tale determinismo può costituire un ostacolo alla piena comprensione dei processi di strutturazione delle organizzazioni. Inoltre, la cosiddetta corrente delle contingenze strategiche, sviluppatasi in particolare con gli studi di Child, rileva che lo stato delle tecnologie e le altre condizioni ambientali comportano solo vincoli deboli e generali sulla struttura, sottolineando invece il ruolo della strategia. |
|
|||||
|
5.2 |
Scuola socio-tecnica |
Trist e Bamforth (1951), Emery (1959), Emery e Trist (1960), Emery e Thorsrud (1964) |
D'ispirazione sistemica, la scuola socio-tecnica è il frutto degli studi degli psicologi e dei sociologi dell'Istituto Tavistock delle relazioni umane di Londra e dell'Istituto del Lavoro di Oslo. Il suo apporto essenziale consiste nel considerare l'organizzazione come un sistema aperto composto da un sistema tecno-economico e da un sistema sociale. Le forze tecniche, economiche e sociali sono tra loro interdipendenti, eper tale motivo devono essere considerate congiuntamente. Da un punto di vista pragmatico, la scuola socio-tecnica esprime un insieme di principi di organizzazione del lavoro sostanzialmente opposti ai principi di Taylor e che si basano sulla capacità autonoma dei lavoratori di organizzarsi in gruppi e di autoregolarsi. |
|
|||||
|
6 |
CORRENTE AZIONISTA |
Berger e Luckman (1967), Thompson (1967), Weick (1969), Silverman (1971) |
La corrente azionista affonda le sue radici nel pensiero di Weber e nella sua concezione di azione sociale come azione che può essere compresa solo tenendo conto del significato che essa assume per coloro che vi sono coinvolti, con l'influenza del pensiero del filosofo sociale Robert Mead, uno dei fondatori dell'interazionismo simbolico. Gli azionisti si oppongono al funzionalismo e alla tendenza di reificazione propria di un approccio sistemico che tende a considerare i comportamenti come frutto di un processo impersonale e vincolante per gli attori. Questa corrente assume il tempo come variabile fondamentale e pone l'enfasi sui processi, cioè sull'organizzare piuttosto che sull'organizzazione. L'universo organizzativo è socialmente costruito e le spiegazioni delle azioni umane devono tenere conto dei significati che gli interessati attribuiscono alle stesse. Questi significati sono dati dalla società ma possono venire modificati dalle azioni umane. La spiegazione positivista, che afferma che l'azione è determinata da forze vincolanti ed esterne, diviene dunque inammissibile. |
Romanzi: "La mossa del cavallo", Camilleri(1999) |
|||||
|
7 |
CORRENTE DELL'ANALISI STRATEGICA |
Crozier (1963), Crozier e Friedberg (1977) |
La corrente dell'analisi strategica considera l'organizzazione come un costrutto sociale composto da attori che sviluppano strategie individuali, come un sistema d'azione concreto dove si dispiegano le differenti strategie degli attori. In opposizione al determinismo, questa corrente insiste sulla libertà relativa di cui dispone ciascun attore in seno al quadro organizzativo e sulle fonti di potere che può attivare per ottimizzare la sua strategia (gestione delle zone di incertezza). L'analisi strategica rimette in primo piano il fenomeno del potere, trascurato da molte teorie dell'organizzazione dopo i contributi di Weber. |
|
|||||
|
8 |
CORRENTE CULTURALISTA |
Smircich (1983), Schein (1985) |
La corrente culturalista, che si sviluppa alla fine degli anni 70, indaga in profondità il concetto di cultura organizzativa, secondo vari punti di vista. Un primo gruppo di autori adotta una prospettiva manageriale interpretando la cultura organizzativa come una variabile interna da cui dipende l'organizzazione e la sua efficacia. Certi autori giungono a considerarla un fattore chiave che si può deliberatamente costruire e propongono anche dei modelli di cultura vincente. Altri prendono le distanze da questa concezione che vedono come caricaturale, osservando che i tratti culturali di un'organizzazione provengono da molteplici fonti di influenza e mettono l'accento sulle responsabilità dei dirigenti in materia di sviluppo culturale. Questa seconda prospettiva, di taglio socio-antropologico, si oppone alla visione strumentale della cultura alla base della tendenza manageriale e manifesta una particolare attenzione alla comprensione del fenomeno. Essa tende a restituire l'universo culturale delle organizzazioni in tutta la sua complessità e a mettere in evidenza i fenomeni simbolici (simboli, riti, rituali, linguaggi, miti e credenze, rappresentazioni) che si ispirano all'antropologia, all'interazionismo simbolico, alla teoria del linguaggio e alle ricerche sulla cognizione. |
|
|||||
|
9 |
ECOLOGIA DELLE POPOLAZIONI |
Hannan e Freeman (1977), Aldrich (1979), Carrol (1984) |
L'ecologia delle popolazioni si ispira alle scienze biologiche e in particolare ai lavori di Darwin. Essa si differenzia dagli altri approcci per il focus sulle "popolazioni" di organizzazioni piuttosto che sulle singole entità. Il concetto fondamentale è quello della selezione naturale come processo primario di cambiamento organizzativo: gli ambienti operano una selezione differenziale tra le organizzazioni ai fini della loro sopravvivenza, sulla base della congruenza tra forme organizzative e caratteristiche ambientali. Alcuni studiosi (es. Hannan e Freeman 1977) si sono soffermati soprattutto sulla mortalità organizzativa quale vettore primario della selezione naturale; altri invece (Carrol 1984) puntano la loro attenzione sul tasso di natalità. |
|
|||||
|
10 |
TEORIA DELLA DIPENDENZA DALLE RISORSE |
Pfeffer e Salancik (1978) |
Mentre l'ecologia delle popolazioni accentua il processo di selezione, la teoria della dipendenza dalle risorse sottolinea invece i processi tendenti ad adattare, plasmare e trasformare a proprio favore l'ambiente esterno. Si assume cioè che le singole organizzazioni possano agire in modo da migliorare le proprie possibilità di sopravvivenza. Uno dei maggiori contributi di questa prospettiva è quello di avere individuato e descritto le strategie utilizzate dalle organizzazioni per modificare l'ambiente o per adattarvisi. Esse possono spaziare dall'istituzione di ruoli di collegamento (strategie-cuscinetto) sino alla diversificazione e alla fusione. |
Film: "Il rapporto Pelican", Pakula (1993) "Erin Brockovich", Soderbergh (2000) "Insider- dietro la verità", Mann (1999) (tema del controllo dell'ambiente da parte delle grandi organizzazioni) Romanzi: "Jacaré", Sepulveda (2001) |
|||||
|
11 |
TEORIA DEI COSTI DI TRANSAZIONE |
Williamson (1975) |
Gli studi di Oliver Williamson si sviluppano partendo dalla critica alle teorie economiche neoclassiche (Coase 1937) che si basano su ipotesi eccessivamente semplificatrici e irrealistiche come quelle degli agenti perfettamente razionali e completamente informati e delle imprese come sistemi per gestire funzioni di produzione, le cui decisioni principali sono unicamente concentrate sulla combinazione ottimale dei fattori produttivi. Per tener conto della maggiore complessità che si osserva nell'economia reale, Williamson utilizza due concetti fondamentali: quello di razionalità limitata, mutuato dagli studi di Barnard e di Simon, e quello di transazione. Spostando l'attenzione dalla produzione di merci alle transazioni, ossia allo scambio di beni e servizi, egli sottolinea l'importanza delle strutture che governano tali scambi. Due sono i principali tipi di controllo alternativi: il "mercato" e l"organizzazione" o "gerarchia". In un sistema di mercato, gli scambi hanno luogo tra acquirenti e venditori sulla base di accordi contrattuali negoziati. Queste transazioni sono governate dal sistema dei prezzi. In situazioni di crescente incertezza, diviene sempre più difficile e costoso sottoscrivere contratti che tengano conto di ogni possibile contingenza. In tali circostanze la produzione e il controllo interno delle unità produttive (cioè il ricorso alla gerarchia) può risultare preferibile rispetto alle transazioni mediate dal mercato. Williamson identifica le condizioni che guidano la scelta tra gerarchia e mercato. Tra queste figurano l'incertezza e la complessità: quando le capacità di trattamento dell'informazione diventano insufficienti a fronteggiare complessità e incertezza, si rendono necessari dei meccanismi alternativi al mercato. Incorporare decisori individuali in assetti organizzativi mediante la gerarchia è una di queste alternative. Due ulteriori condizioni nella scelta tra mercato e gerarchia sono espresse dai concetti di opportunismo e piccoli numeri. Il primo si fonda sull'osservazione che gli individui sono capaci di ricercare l'interesse personale anche tramite l'inganno e questo può richiedere il ricorso a forme di controllo più efficaci del mercato come le gerarchie. Per quanto riguarda il secondo, Williamson osserva che i rischi connessi a situazioni di quasi monopolio caratterizzate da un numero ristretto di partner alternativi (piccoli numeri), possono anch'essi rendere conveniente il ricorso alle gerarchie. Mercato e gerarchia differiscono anche con riferimento alla natura delle transazioni che avvengono tra i partner. Negli anni '20 l'economista istituzionale John Commons per primo analizzò la natura particolare del contratto di lavoro osservando che ciò che l'operaio vende "... quando vende il suo lavoro è la disponibilità a usare le sue capacità ad uno scopo che gli è stato indicato. Egli vende la sua promessa di obbedire ai comandi". (Commons 1924, pag. 284). In condizioni di incertezza i vantaggi di questo contratto "aperto" sono evidenti: l'obbedienza viene garantita nei confronti di una gamma generica di ordini; indicazioni specifiche verranno impartite a seguito delle variabili e imprevedibili esigenze delle situazioni contingenti. In definitiva, il ricorso alla gerarchia riduce i costi di transazione in condizioni di incertezza e di scambio limitato. La teoria dei costi di transazione permette dunque di spiegare in quale modo le singole organizzazioni determinano i propri confini e progettano i propri sistemi di governo. |
Film: "Paul, Mick e gli altri", Loach (2001)(tema dell'outsourcìng) "A beautiful mind", Howard (2002) (tema dei meccanismi negoziazione - equilibrio di Nash) |
|||||
|
12 |
NEOISTITUZIONALISMO |
Meyer & Rowan (1977), DiMaggio e Powell(1983), Meyer e Scott (1983), Zucker (1977, 91) |
I lavori neoistituzionali attingono ad una varietà di discipline, dalla sociologia all'economia alla scienza politica. La nascita della corrente in campo organizzativo viene solitamente ricondotta alla pubblicazione nel 1977 dell'articolo di Meyer e Rowan e di quello di Zucker, entrambi basati sulla nozione di istituzione avanzata dagli studiosi della corrente azionista, e in particolare da Silverman(1971), che si rifaceva a sua volta ai lavori di Berger e Luckmann(1967). A differenza degli istituzionalisti classici, che sottolineavano l'aspetto normativo delle istituzioni, la corrente neoistituzionale incentra l'attenzione sulla dimensione cognitiva. Le organizzazioni sono considerate come strutturate dal loro ambiente, attraverso un continuo processo in cui le professioni, gli stati nazionali e i mass media contribuiscono a razionalizzare le norme culturali che ne costituiscono l'essenza. Le organizzazioni riflettono dunque una società costruita socialmente e in questo processo tendono ad assumere forme simili (isomorfismo istituzionale), incorporando elementi che sono legittimati all'esterno più che giustificati da considerazioni di efficienza o da logiche interne. DiMaggio e Powell hanno teorizzato l'esistenza di importanti meccanismi - coercitivi, mimetici e normativi - attraverso i quali certi effetti istituzionali si diffonderebbero nelle organizzazioni, mentre Meyer e Scott hanno posto l'enfasi sull'esistenza di forze sia tecniche sia istituzionali, che agirebbero in modo diverso in diversi tipi di organizzazioni. Zucker infine (un'allieva di Meyer) sottolinea i micro-fondamenti delle istutuzioni, richiamando l'attenzione sulle credenze cognitive che guidano il comportamento: "le conoscenze sociali, una volta istituzionalizzate, esistono come un dato di fatto, come parte della realtà oggettiva, e come tali possono essere trasmesse in modo diretto". (Zucker 1977, pag. 726). |
|
|||||
|
13 |
CORRENTE CRITICA |
Braverman (1974), Clegg e Dunkerley (1977) |
D'ispirazione marxista, questa corrente sviluppa un'analisi delle organizzazioni dalla prospettiva dei rapporti di potere/controllo e denuncia il carattere ideologico delle logiche manageriali. Questi studi sottolineano la dequalificazione del lavoro generato dal capitalismo industriale, i processi di controllo del personale legati ai sistemi burocratici, la segmentazione del mercato del lavoro. |
Film: “Risorse umane”, Cantet (1999) "Il vangelo secondo precario", Obino (2005) |
|||||
|
14 |
TEORIE POSTMODERNE |
Smircich e Calas (1987), Cooper e Burrel(1988), Alvesson e Deetz (1996) |
Gli scritti postmoderni, che si rifanno largamente ad autori francesi come Barthes, Derrida, Focault, si sono sviluppati con diverse varianti e significati. La stessa espressione "teorie postmoderne" è utilizzata per designare un periodo particolare marcato da importanti cambiamenti organizzativi (le nuove forme organizzative flessibili e/o partecipative) o da un insieme di approcci e nuove prospettive sullo studio delle organizzazioni. In questa seconda accezione, i temi del postmodernismo si focalizzano sulla centralità del discorso e sul potere costitutivo del linguaggio, sulla ricerca di strutture permanenti che si riproducono indipendentemente dagli attori, sulla decodifica di sistemi di credenze e discorsi rispetto a queste strutture, sul declino dei grandi progetti politici, sui legami tra potere e conoscenza. L’approccio postmodernista è arrivato alle teorie dell’organizzazioni dopo essere stato applicato al campo della linguistica, della semiotica e della teoria letteraria, ed è stato sostenuto dall’interesse per i significati e le interpretazioni stimolato dall’approccio simbolico-interpretativo all’analisi delle organizzazioni. La visione postmodernista della realtà è un concetto poliedrico, frammentato e contraddittorio. |
Film: "American Beauty", Mendes (1999) "L'attimo fuggente", Weir (1989) (temi di potere/conoscenza e ribellione) Romanzo: "Volevo solo dormirle addosso", Lolli (1998) (tema dell'influsso di linguaggio e cultura aziendale sulla vita privata) Film: "C'è posta per te”, Ephron (1998), (tema dei nuovi media/linguaggi nelle relazioni sociali) Romanzo: "Pura vita", De Carlo (2002) (tema dei nuovi media/linguaggi nelle relazioni sociali) |
|||||
|
Progetto Eiderdown Rel. 1.0 - Basato su: http://www.lenzuolo.net. La colonna “Sistemi Informativi” è a cura di Andrea Carugati, Maddalena Sorrentino e Francesco Virili, prevalentemente in base a: J.Iivari, R. Hirschheim e H. K. Klein (2001), A Dynamic Framework for Classifying Information Systems Development Methodologies and Approaches, Journal of Management Information Systems, 17(3), 179-218. La colonna “Riferimenti filosofici” è a cura di Andrea Carugati (IESEG School of Management, Università Cattolica di Lille—Francia), sulla base di: Carugati A. “Information Systems Development as Inquiring Systems: Lessons from Philosophy, Theory, and Practice”, International Conference on Information Systems ICIS, Las Vegas, December 11-14, 2005. La colonna “Riferimenti musicali” è a cura di Annamaria Morazzoni (Università Milano Bicocca) e di Daniela Isari (Università Cattolica di Milano). La colonna “Descrizione” delle scuole e prospettive organizzative è stata in parte rivista e integrata da Massimo Magni (Università Bocconi) e Maddalena Sorrentino (Università Statale di Milano). La colonna “Film e romanzi” è stata integrata e rivista da Francesco Virili (Università degli Studi di Cassino), grazie anche ai contributi e suggerimenti di Andrea Carugati (IESEG School of Management, Università Cattolica di Lille—Francia), di Angelo Gasparre (Università degli Studi di Genova) e di Elena Perondi (Università Cattolica di Milano). La versione inglese di Eiderdown è a cura di Valentina Albano (Università LUISS Roma, Katia Passerini (New Jersey Institute of Technology) ed Elena Perondi (Università Cattolica di Milano). |
|||||||||