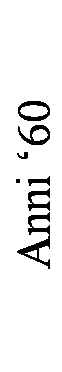
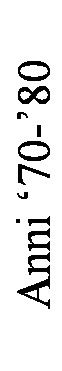
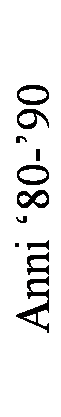
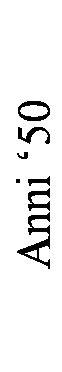
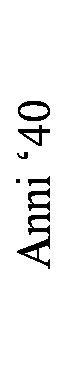
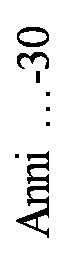
|
|
Scuole e prospettive organizzative |
Autori |
Descrizione |
Periodo |
Approcci e metodologie di sviluppo dei sistemi
informativi |
Information and |
Riferimenti culturali |
Film/Romanzi |
|
1 |
PROSPETTIVA
CLASSICA |
|
Teoria che privilegia lo studio degli aspetti formali
delle organizzazioni ed enuncia i principi universali di gestione. La corrente delle "relazioni
umane" arricchirà l'analisi organizzativa con la scoperta degli aspetti
informali; i lavori di analisi comparativa mostreranno i limiti del progetto
di enunciazione di principi universali di gestione. |
|
|
Intorno al
1810: Scheda perforata 1904 Valvole
elettroniche 1905 Calcolatrice
elettrica 1914 Calcolatore
con numeri in virgola mobile 1932 Memoria
basata su relais 1937 Primo
centro di calcolo (Londra) Macchina di Turing 1938 Primo calcolatore programmabile dall'utente
(Z1) |
Smith (1776), Marx (1867), Durkheim (1893) |
|
|
1.1 |
Organizzazione
scientifica del lavoro |
Taylor (1895, 1903, 1911) |
Il
modello organizzativo proposto da Taylor si caratterizza per una divisione
del lavoro chiaramente definita e per la presenza di una forte gerarchia che
assicura il coordinamento dei diversi compiti. Essenza del nuovo sistema di
gestione e direzione: 1) Sviluppo di conoscenze su basi scientifiche; 2)
Selezione scientifica della manodopera; 3) preparazione e perfezionamento dei
lavoratori su basi scientifiche; 4) intima e cordiale collaborazione fra
dirigenti e manodopera. |
|
Barnard(1938) |
Film: "Tempi moderni", Chaplin (1936) |
||
|
1.2 |
Scuola dei
principi di amministrazione |
Fayol (1916), Mooney (1937)
Mooney e Reiley (1939), Gulick e Urwick (1937) |
Fayol
enuncia 14 principi di amministrazione. Egli è principalmente interessato
alla funzione amministrativa, che considera la meno compresa e la più
trascurata, mentre invece è la più importante. Gli elementi della struttura
sono i seguenti: pianificazione, organizzazione, comando, coordinamento,
controllo. |
|
|
|
||
|
1.3 |
Teoria
della burocrazia |
Weber (1922) (trad. ing. 1947) |
Descrizione della burocrazia come tipo "ideale" di organizzazione cioè come una forma pura particolarmente adatta per la gestione e il funzionamento delle istituzioni pubbliche. Il concetto di burocrazia si ricollega direttamente al modo legale-razionale di esercizio dell'autorità, che è uno dei temi centrali del pensiero di Weber. La burocrazia si caratterizza per una ben definita gerarchia dell'autorità, per la specializzazione dei compiti, per un funzionamento basato su regole e procedure formali. L'obiettivo è quello di garantire sia l'efficienza nell'esecuzione dei compiti sia l'equità nel trattamento del personale e degli utenti. I lavori di analisi comparativa mostrano che queste modalità di gestione possono valere anche al di fuori delle organizzazioni pubbliche e che esistono nella realtà più forme di burocrazia. Le conseguenze inattese di questo tipo di organizzazione, come l'alienazione degli attori, la trasposizione fini-mezzi, l'apatia, la rigidità di funzionamento, hanno ricevuto una grande attenzione (vedi Airoldi pag. 15: Merton, Selznick, Etzioni, fino a Crozier. Vedi anche manuale 1-20: Parson, Gouldner, Blau, Scott) |
|
|
1941 Primo
calcolatore comandato da un programma (Z3) 1943 Calcolatore
Colossus, usato per decifrare codici in ambito militare 1944 Calcolatore
Harvard-Mark-I, memoria a tamburo magnetico 1945 Nasce
Pankalkul primo linguaggio di programmazione 1946 Principi
di Von Neumann per calcolatori universali Primo
calcolatore completamente elettronico (ENIAC) 1947 Nascita
della prima versione di transistor Calcolatore
analogico a elevate prestazioni Basi
della teoria dell'informazione 1948 A
Manchester il Mark I,
primo
computer moderno, esegue il
primo programma, con una memoria di 96 words, con una velocità di 1
istruzione ogni 1,2 millisecondi 0,00083 MIPS). Seguirà solo nel 1952 l’EDVAC
di Von Neumann. |
Simon(1945) |
Film: "Brazil", Guilliams (1985) (tema del
delirio della burocrazia) Romanzi:
“Tutti i nomi” Saramago (1998) (tema della crisi e
del cambiamento nella burocrazia) "1984",
Orwell (1949) (tema del delirio della burocrazia) "Il cavaliere inesistente", Calvino (1959)
(metafora sul tema umanità e burocrazia) |
|
2 |
SCUOLA
BEHAVIORISTA |
|
Questo movimento nasce intorno agli anni 30 da due filoni di ricerca principali: l'opera di Chester Barnard e i cosiddetti esperimenti di Hawtorn. L'opera di Barnard "The Functions of the Executive" ha costituito uno dei primi tentativi sistematici di elaborare una teoria dell'organizzazione che ha avuto una grande influenza sia sul pensiero behaviorista, sia sulle concezioni istituzionaliste di Selznick e sulla teoria delle decisioni di Simon. Gli esperimenti di Hawthorne furono condotti in uno stabilimento della Western Electric Co da Roethlisberger e Dickson e successivamente analizzati ed interpretati da Mayo. In opposizione all'orientamento essenzialmente strutturale della teoria classica, la scuola behaviorista sviluppa una diversa visione, incentrata sulla natura umana e sul comportamento degli attori nelle organizzazioni. Non si tratta di ignorare la struttura organizzativa ma di mostrare in che cosa questa è modellata dai bisogni, dalle capacità, dai limiti degli individui e in quale misura essa influenza i loro comportamenti. Questi approcci comportamentali si focalizzano più volentieri sull'analisi dei processi di funzionamento delle organizzazioni. Esistono tuttavia differenze importanti tra le manifestazioni di questo orientamento behaviorista: differenze sul piano delle variabili considerate più rilevanti, nonché sul diverso approccio. Esso è di tipo normativo per le correnti delle relazioni e delle risorse umane; mentre è più fondamentalmente descrittivo presso i teorici della scuola Carnegie. |
|
|
|
||
|
2.1 |
Movimento
delle "relazioni umane" |
Barnard (1938), Roethlisberger e Dickson (1939),
Mayo (1933,45) |
Raggruppa più ambiti di ricerca con obiettivi omogenei: lo studio del funzionamento dei gruppi di lavoro, quello dei fenomeni informali nelle organizzazioni, la questione degli stili di supervisione. Nell'insieme il movimento delle relazioni umane mette in evidenza l'importanza del fattore umano nelle organizzazioni e la necessità di mettere in conto i bisogni sociali e di stima degli individui per accrescere la produttività. Viene proposto uno stile di gestione partecipativo. I limiti di questo movimento consistono in una visione incompleta dei bisogni e dei comportamenti degli individui, una certa ingenuità nell'interpretazione dei conflitti e la preconizzazione di pratiche di gestione che possono degenerare in manipolazione. |
|
|
|
||
|
2.2 |
Corrente
"Carnegie" (o delle decisioni) |
Simon (1947, 1957), March e Simon (1958), Cyert e
March (1963) |
I teorici della corrente Carnegie, i cui primi lavori risalgono alla fine degli anni ‘40, esplorano le conseguenze organizzative delle capacità limitate dell'individuo in termini di trattamento dell'informazione e di risoluzione dei problemi. I loro contributi alla comprensione dei processi decisionali nell'organizzazione sono fondamentali. Si deve loro la nozione di razionalità limitata, la nozione di apprendimento organizzativo e la visione dell'organizzazione come coalizione mutevole di interessi molteplici e conflittuali che i principali decisori cercano di soddisfare in modo sequenziale (nozione della quasi-risoluzione dei conflitti). Mentre nelle due correnti precedenti la variabile organizzativa sulla quale è posta una maggiore importanza è il clima organizzativo, con la corrente Carnegie l'enfasi è posta prevalentemente sul modo in cui il comportamento degli individui è programmato da procedure operative ed euristiche, sugli aspetti politici del funzionamento delle organizzazioni e sui processi decisionali. La corrente Carnegie si avvale anche degli apporti della matematica applicata e della ricerca operativa e fa riferimento, per la prima volta in modo sistematico, all'utilizzo di strumenti automatici per il trattamento dell'informazione e per il supporto alle decisioni. Un aspetto fortemente innovativo è la focalizzazione su due specifiche componenti della dinamica organizzativa: l'informazione e la decisione. |
|
|
1950 Presentazione
del "Test di Turing" 1951 Costruzione
in serie del primo calcolatore elettronico prodotto su scala commerciale
(Univac I, 5.600 valvole, 18.000 diodi, 19 t di peso, 1 milione di dollari) Avvio delle applicazioni commerciali degli
elaboratori 1952 Memoria
a nastro magnetico 1953 Costruzione
in serie di un grande calcolatore (IBM 701) basato su tecnologia a valvole 1954 Versione
perfezionata (e a basso costo) del transistor 1955 TRADIC,
primo computer completamente a transistor Linguaggio IPL-II, primo linguaggio per lo
sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale 1956 Primo
sistema operativo (destinato all'elaboratore IBM 704) Logic Theorist, primo programma basato su
tecniche di intelligenza artificiale Utilizzo sperimentale della tastiera per
introdurre dati e comandi 1957 Nasce il linguaggio
FORTRAN. La prima applicazione ha luogo
presso la Westinghouse 1958 Primo
circuito integrato 1959 Nasce ERMA, primo sistema di lettura di
caratteri magnetici. Il primo utente è la Bank of America |
Parsons(1951), Gouldner(1954), Simon(1958),
March(1958), Dalton(1959) |
Film: "2001 Odissea nello spazio", Kubrick
(1968) "Guerre Stellari" Lucas (1977) (tema del mito degli automi intelligenti) |
|
2.3 |
Corrente
delle "risorse umane" (o nuove relazioni umane) |
Argyris (1957, 1962), Herzberg, Mausner e
Snyderman (1959), McGregor (1960), Likert(1961), Herzberg (1966) |
Come il movimento delle relazioni umane, così anche la corrente delle risorse umane, che nasce verso la metà degli anni 50, dà molta importanza alla questione della motivazione degli individui, ma più che i bisogni sociali e di stima sono i bisogni di realizzazione di sé, di attuazione del proprio potenziale che sono considerati come fondamentali. Si tratta di mettere in atto forme organizzative che permettano agli individui di esprimere il proprio potenziale. Tali forme, essenzialmente partecipative, si contrappongono ai principi classici e burocratici dell'organizzazione, considerati come fonte di frustrazione degli individui e di spreco dei loro talenti. I principali contributi di questa corrente portano alla gestione del cambiamento, alla gestione dei conflitti e alle pratiche di sviluppo delle risorse umane. Questa corrente condivide con il movimento delle relazioni umane una certa ingenuità nell'interpretazione dei conflitti e una sopravvalutazione delle questioni della motivazione a spese di quelle relative alle proprietà cognitive degli individui. Come nelle teorie classiche, si cede alla tentazione di proporre principi di portata universale. |
|
|
Film: "A tempo pieno", Cantet (2001), scena del
protagonista che dorme in macchina (tema delle motivazioni — scala di Maslow) |
||
|
3 |
SCUOLA
FUNZIONALISTA |
Parsons (1951), Merton et al. (1952), Merton(1957) |
Il funzionalismo affonda le sue radici nei lavori di Comte, Spencer, Pareto e Durkheim. Parsons ha sviluppato un modello generale adatto all'analisi di ogni tipo di collettività, dai piccoli gruppi primari alle intere società. Gli studi di Parsons definiscono le quattro funzioni fondamentali che tutti i sistemi sociali devono svolgere per sopravvivere, individuate dalla sigla AGIL (Adaptation, Goal, Integration, Latency). Adaptation: il problema di raccogliere risorse sufficienti. Goal: il problema della definizione e del raggiungimento degli obiettivi. Integration: il problema del coordinamento tra le sottounità del sistema. Latency: il problema del creare, conservare e trasmettere la cultura specifica e i valori del sistema. Il modello AGIL può essere applicato per stabilire un collegamento funzionale tra le organizzazioni e la società (livello ecologico); a livello di analisi strutturale, invece, esso definisce i sottosistemi differenziati che ogni organizzazione deve sviluppare per far fronte alle quattro esigenze fondamentali. Gli studi di Merton si concentrano inizialmente sull'analisi degli aspetti di degenerazione del tipo ideale di burocrazia descitto da Weber, che fu tradotto in inglese alla fine degli anni '40. In particolare è noto nella letteratura organizzativa per la descrizione delle disfunzioni burocratiche e del fenomeno della trasposizione fini-mezzi. Merton riesce a chiarire e a rimettere a punto alcuni aspetti fondamentali della teoria funzionalista. I più importanti sono: l'accento sulle disfunzioni, la distinzione tra funzioni manifeste e latenti, il concetto di alternativa funzionale e l'insistenza sull'importanza di scoprire e comprendere i meccanismi che assolvono a determinate funzioni. Tuttavia Merton abbandona la ricerca di una teoria omnicomprensiva (tipica dell'approccio funzionale) per assumere una prospettiva definita "teoria di medio raggio". Essa è caratterizzata da una serie limitata di presupposti da cui si possono derivare e verificare empiricamente delle ipotesi specifiche. |
|
|
Film: "Un giorno di ordinaria follia",
Schumacher (1993), scena del McDonald (tema della trasposizione fini-mezzi di
Merton) |
||
|
4 |
SCUOLA
ISTITUZIONALE |
Selznick (1949, 1957) Perrow (1961) |
Secondo
Selznick, che ha avuto Perrow come allievo, "La cosa più importante per
le organizzazioni è che, sebbene siano degli strumenti, nondimeno ciascuna ha
una vita sua propria" (Selznick, 1949, trad. it. 1974, pag. 25).
Selznick designa il processo attraverso il quale un'organizzazione sviluppa
un suo particolare carattere come "istituzionalizzazione". Per questo autore, istituzionalizzato
significa "infuso di valore al di là delle esigenze tecniche del compito
immediato" (1957, pag. 24 nella trad. it. del 1976). |
|
|
Film: "Lanterne rosse", Yimou (1991) "Una poltrona per due", Landis (1983) "Il fascino discreto della borgesia",
Bunuel (1972) (tema del condizionamento sociale e istituzionale) |
||
|
5 |
TEORIE
SISTEMICHE
Teoria dell'organizzazione come sistema aperto |
Beer (1964), Haberstroh (1965),
Katz e Kahn(1966) |
L'approccio sistemico, che si ispira alla Gestalt Theorie, vede l'organizzazione come un tutto inserito in un ambiente con il quale intrattiene relazioni di input/output di energia. Questo insieme è scomponibile in sottoinsiemi, ma sono le relazioni tra questi che sono essenziali per comprendere il funzionamento del tutto (il quale è diverso dalla somma delle parti). L'approccio sistemico apporta numerosi contributi agli studi di organizzazione: l'enunciazione degli attributi e delle proprietà dei sistemi aperti verso un ambiente esterno (ciclo di trasformazione dell'energia, nozioni di entropia, omeostasi, differenziazione, equifinalità); l'identificazione dei componenti di un sistema, l'analisi delle loro interazioni, l'analisi delle forze che modellano un sistema, etc. Questa scuola ha fornito contributi descrittivi, che offono un apporto alla conoscenza del funzionamento delle organizzazioni, ed anche prescrittivi, con delle formulazioni che si iscrivono nella concezione cibernetica, ispirata alla scienza dei meccanismi autoregolati. Tra questi gli studi di Haberstroh hanno definito per la prima volta il concetto di scatola nera. |
|
|
1960 Linguaggio
COBOL Nasce
Dataphone, primo modem commerciale Costruzione
del primo apparecchio Laser Anni '60: sviluppo del primo
DBMS (IDS) 1962 Circuito
integrato (chip) 1963 Nasce
lo standard ASCII, per l'interscambio di dati tra computer 1964 Calcolatore
con circuiti integrati Prima applicazione di on-line
transaction processing (sistema SABRE di American Airlines) per collegare
2.000 terminali in 65 città Linguaggio BASIC 1965 Dendral,
primo sistema esperto sviluppato all'Università di Stanford 1966 L'informatica
come disciplina scolastica 1969 Nasce il sistema operativo
Unix Progettazione rete
ARPANET |
von Berthalanffy(1968) |
|
|
5.1 |
Teoria
delle contingenze strutturali |
Burns e Stalker (1961),
Woodward (1965), Lawrence e Lorsch(1967), gruppo di Aston (Pugh, Hinings,
Hickson), Child (1972) Galbraith (1973, 1977) |
I teorici della contingenza identificano le variabili che hanno un impatto maggiore sulla struttura organizzativa. Secondo queste scuole, le variabili di contesto o di situazione impongono dei vincoli organizzativi ai quali è necessario conformarsi (le variabili di contesto in questione sono, secondo gli autori: tecnologia, dimensioni, ambiente, strategia, cultura organizzativa). Sviluppando inoltre una concezione relativista dell'organizzazione, i teorici della contingenza si oppongono al principio di organizzazione universale delle teorie classiche. Le scuole contingentiste hanno avuto ed hanno tuttora un impatto importante sulla teoria organizzativa. Esse sono tuttavia caratterizzate da un forte determinismo, che può essere di ostacolo alla piena comprensione dei processi di strutturazione delle organizzazioni. La cosiddetta corrente delle contingenze strategiche, sviluppatasi in particolare con gli studi di Child, rileva che lo stato delle tecnologie e le altre condizioni ambientali comportano solo vincoli deboli e generali sulla struttura, sottolineando invece il ruolo della strategia. |
|
|
|
||
|
5.2 |
Scuola
socio-tecnica |
Trist e Bamforth (1951),
Emery (1959), Emery e Trist (1960), Emery e Thorsrud (1964) |
D'ispirazione sistemica, la scuola socio-tecnica è il frutto degli studi degli psicologi e dei sociologi dell'Istituto Tavistock delle relazioni umane di Londra e dell'Istituto del Lavoro di Oslo. Il suo apporto essenziale consiste nel considerare l'organizzazione come un sistema aperto composto da un sistema tecno-economico e da un sistema sociale che bisogna ottimizzare congiuntamente nella misura in cui le forze tecniche, economiche e sociali che si esercitano sul sistema organizzativo sono interdipendenti. Da un punto di vista pragmatico, la scuola socio-tecnica esprime un insieme di principi di organizzazione del lavoro sostanzialmente opposti ai principi di Taylor e che si basano sulla capacità autonoma dei lavoratori di organizzarsi in gruppi e di autoregolarsi. |
|
|
|
||
|
6 |
CORRENTE
AZIONISTA |
Berger e Luckman (1967), Thompson (1967), Weick (1969), Silverman (1971) |
La corrente azionista affonda le sue radici nel pensiero di Weber e nella sua concezione di azione sociale come azione che può essere compresa solo tenendo conto del significato che essa assume per coloro che vi sono coinvolti, con l'influenza del pensiero del filosofo sociale Robert Mead, uno dei fondatori dell'interazionismo simbolico. Gli azionisti si oppongono al funzionalismo e alla tendenza di reificazione propria di un certo approccio sistemico che tende a considerare i comportamenti come frutto di un processo impersonale e vincolante per gli attori. Questa corrente assume il tempo come variabile fondamentale e pone l'enfasi sui processi, cioè sull'organizzare piuttosto che sull'organizzazione. L'universo organizzativo è socialmente costruito e le spiegazioni delle azioni umane devono tenere conto dei significati che gli interessati attribuiscono alle loro azioni. Questi significati sono dati dalla società ma possono venire modificati dalle azioni umane. La spiegazione positivista, che afferma che l'azione è determinata da forze vincolanti ed esterne, diviene dunque inammissibile. |
|
Myrdal (1969) |
|
||
|
7 |
CORRENTE
DELL'ANALISI STRATEGICA |
Crozier (1963), Crozier e
Friedberg (1977) |
La corrente dell'analisi
strategica considera l'organizzazione come un costrutto sociale composto da
attori che sviluppano strategie individuali, come un sistema d'azione
concreto dove si dispiegano le differenti strategie degli attori. In
opposizione al determinismo, questa corrente insiste sulla libertà relativa
di cui dispone ciascun attore in seno al quadro organizzativo e sulle fonti
di potere che può attivare per ottimizzare la sua strategia (gestione delle
zone di incertezza). L'analisi strategica rimette in primo piano il fenomeno
del potere, trascurato da molte teorie dell'organizzazione dopo i contributi
di Weber. |
|
DeMarco (1979), Yourdon (1989) · Approccio
"Information Modeling" Chen
(1976), Martin (1989) · Approccio
"Decision Support Systems" Keen e Scott-Morton (1978), Sprague e
Carlsson (1982) · Approccio
socio-tecnico Mumford (1983), Pava (1983, 86) · Approccio
info-logico Lundeberg, Goldkuhl e Nilsson, (1981) |
Whyte(1943), Schutz(1932), Goffman(1971),
Geertz(1973) |
|
|
|
8 |
CORRENTE
CULTURALISTA |
Smircich (1983), Schein (1985) |
La corrente culturalista, che si sviluppa alla fine degli anni 70, indaga in profondità il concetto di cultura organizzativa, secondo vari punti di vista. Un primo gruppo di autori adotta una prospettiva manageriale interpretando la cultura organizzativa come una variabile interna da cui dipende l'organizzazione e la sua efficacia. Certi autori giungono a considerarla un fattore chiave che si può deliberatamente costruire e propongono anche dei modelli di cultura vincente. Altri prendono le distanze da questa concezione che vedono come caricaturale, osservando che i tratti culturali di un'organizzazione provengono da molteplici fonti di influenza e mettono l'accento sulle responsabilità dei dirigenti in materia di sviluppo culturale. Questa seconda prospettiva, di taglio socio-antropologico, si oppone alla visione strumentale della cultura alla base della tendenza manageriale e manifesta una particolare attenzione alla comprensione del fenomeno. Essa tende a restituire l'universo culturale delle organizzazioni in tutta la sua complessità e a mettere in evidenza i fenomeni simbolici (simboli, riti, rituali, linguaggi, miti e credenze, rappresentazioni) che si ispirano all'antropologia, all'interazionismo simbolico, alla teoria del linguaggio e alle ricerche sulla cognizione. |
1970 Prima
legge sulla protezione dei dati Definizione del modello relazionale Primo distributore di contanti presso
la Citizens and Southern Bank Realizzazione dei primi 4 nodi di
ARPANET 1971 Primo
floppy disk da 8 pollici 1972 Nasce
8008, microprocessore a 8 bit Supercomputer (CRAY-1) SmallTalk, primo linguaggio
object-oriented 1973 Nasce
Ethernet presso il centro di ricerche Xerox
di Palo Alto 1974
Primo PC
(Mark-8) 1976 Definizione
del modello Entità-Relazioni Commutatore ottico 1978 Primo
floppy disk da 5 1/4 pollici 1979 Sistema
operativo MS-DOS Nascita del linguaggio C++ Visicalc, primo foglio elettronico
sviluppato per Apple II |
|
|
||
|
9 |
ECOLOGIA
DELLE POPOLAZIONI |
Hannan e Freeman (1977),
Aldrich (1979), Carrol (1984) |
L'ecologia delle popolazioni si ispira alle scienze biologiche e in particolare ai lavori di Darwin. Essa si differenzia dagli altri approcci per il focus sulle "popolazioni" di organizzazioni piuttosto che sulle singole entità. Il concetto fondamentale è quello della selezione naturale come processo primario di cambiamento organizzativo: gli ambienti operano una selezione differenziale tra le organizzazioni ai fini della loro sopravvivenza, sulla base della congruenza tra forme organizzative e caratteristiche ambientali. Alcuni studiosi (es. Hannan e Freeman 1977) si sono soffermati soprattutto sulla mortalità organizzativa quale vettore primario della selezione naturale; altri invece (Carrol 1984) puntano la loro attenzione sul tasso di natalità. |
Propp(1828), Barthes(1972), Ricoeur(1981), de
Saussure(1959), Burke(1954) |
|
|||
|
10 |
TEORIA
DELLA DIPENDENZA DALLE RISORSE |
Pfeffer e Salancik (1978) |
Mentre l'ecologia delle
popolazioni accentua il processo di selezione, la teoria della dipendenza
dalle risorse sottolinea invece i processi tendenti ad adattare, plasmare e
trasformare a proprio favore l'ambiente esterno. Si assume cioè che le
singole organizzazioni possano agire in modo da migliorare le proprie
possibilità di sopravvivenza. Uno dei maggiori contributi di questa
prospettiva è quello di avere individuato e descritto le strategie utilizzate
dalle organizzazioni per modificare l'ambiente o per adattarvisi. Esse
possono spaziare dall'istituzione di ruoli di collegamento
(strategie-cuscinetto) sino alla diversificazione e alla fusione. |
|
Film: "Il rapporto Pelican", Pakula (1993) "Erin Brockovich", Soderbergh (2000) "Insider- dietro la verità", Mann (1999)
(tema del controllo dell'ambiente da parte delle grandi organizzazioni) Romanzi: "Jacaré", Sepulveda (2001) |
|||
|
11 |
TEORIA DEI
COSTI DI TRANSAZIONE |
Williamson (1975) |
Gli studi di Oliver Williamson si sviluppano partendo dalla critica alle teorie economiche neoclassiche (Coase 1937) che si basano su ipotesi eccessivamente semplificatrici e irrealistiche come quelle degli agenti perfettamente razionali e completamente informati e delle imprese come sistemi per gestire funzioni di produzione, le cui decisioni principali sono unicamente concentrate sulla combinazione ottimale dei fattori produttivi. Per tener conto della maggiore complessità che si osserva nell'economia reale, Williamson utilizza due concetti fondamentali: quello di razionalità limitata, mutuato dagli studi di Barnard e di Simon, e quello di transazione. Spostando l'attenzione dalla produzione di merci alle transazioni, ossia allo scambio di beni e servizi, egli sottolinea l'importanza delle strutture che governano tali scambi. Due sono i principali tipi di controllo alternativi: il "mercato" e l"organizzazione" o "gerarchia". In un sistema di mercato, gli scambi hanno luogo tra acquirenti e venditori sulla base di accordi contrattuali negoziati. Queste transazioni sono governate dal sistema dei prezzi. In situazioni di crescente incertezza, diviene sempre più difficile e costoso sottoscrivere contratti che tengano conto di ogni possibile contingenza. In tali circostanze la produzione e il controllo interno delle unità produttive (cioè il ricorso alla gerarchia) può risultare preferibile rispetto alle transazioni mediate dal mercato. Williamson identifica le condizioni che guidano la scelta tra gerarchia e mercato. Tra queste figurano l'incertezza e la complessità: quando le capacità di trattamento dell'informazione diventano insufficienti a fronteggiare complessità e incertezza, si rendono necessari dei meccanismi alternativi al mercato. Incorporare decisori individuali in assetti organizzativi mediante la gerarchia è una di queste alternative. Due ulteriori condizioni nella scelta tra mercato e gerarchia sono espresse dai concetti di opportunismo e piccoli numeri. Il primo si fonda sull'osservazione che gli individui sono capaci di ricercare l'interesse personale anche tramite l'inganno e questo può richiedere il ricorso a forme di controllo più efficaci del mercato come le gerarchie. Per quanto riguarda il secondo, Williamson osserva che i rischi connessi a situazioni di quasi monopolio caratterizzate da un numero ristretto di partner alternativi (piccoli numeri), possono anch'essi rendere conveniente il ricorso alle gerarchie. Mercato e gerarchia differiscono anche con riferimento alla natura delle transazioni che avvengono tra i partner. Negli anni '20 l'economista istituzionale John Commons per primo analizzò la natura particolare del contratto di lavoro osservando che ciò che l'operaio vende "... quando vende il suo lavoro è la disponibilità a usare le sue capacità ad uno scopo che gli è stato indicato. Egli vende la sua promessa di obbedire ai comandi". (Commons 1924, pag. 284). In condizioni di incertezza i vantaggi di questo contratto "aperto" sono evidenti: l'obbedienza viene garantita nei confronti di una gamma generica di ordini; indicazioni specifiche verranno impartite a seguito delle variabili e imprevedibili esigenze delle situazioni contingenti. In definitiva, il ricorso alla gerarchia riduce i costi di transazione in condizioni di incertezza e di scambio limitato. La teoria dei costi di transazione permette dunque di spiegare in quale modo le singole organizzazioni determinano i propri confini e progettano i propri sistemi di governo. |
|
Film: "Paul, Mick e gli altri", Loach
(2001)(tema dell'outsourcìng) "A beautiful mind", Howard (2002) (tema
dei meccanismi negoziazione - equilibrio di Nash) |
|||
|
12 |
NEOISTITUZIONALISMO |
Meyer & Rowan (1977), DiMaggio e Powell(1983),
Meyer e Scott (1983), Zucker (1977, 91) |
I lavori neoistituzionali attingono ad una varietà di discipline, dalla sociologia all'economia alla scienza politica. La nascita della corrente in campo organizzativo viene solitamente ricondotta alla pubblicazione nel 1977 dell'articolo di Meyer e Rowan e di quello di Zucker, entrambi basati sulla nozione di istituzione avanzata dagli studiosi della corrente azionista, e in particolare da Silverman(1971), che si rifaceva a sua volta ai lavori di Berger e Luckmann(1967). A differenza degli istituzionalisti classici, che sottolineavano l'aspetto normativo delle istituzioni, la corrente neoistituzionale incentra l'attenzione sulla dimensione cognitiva. Le organizzazioni sono considerate come strutturate dal loro ambiente, attraverso un continuo processo in cui le professioni, gli stati nazionali e i mass media contribuiscono a razionalizzare le norme culturali che ne costituiscono l'essenza. Le organizzazioni riflettono dunque una società costruita socialmente e in questo processo tendono ad assumere forme simili (isomorfismo istituzionale), incorporando elementi che sono legittimati all'esterno più che giustificati da considerazioni di efficienza o da logiche interne. DiMaggio e Powell hanno teorizzato l'esistenza di importanti meccanismi - coercitivi, mimetici e normativi - attraverso i quali certi effetti istituzionali si diffonderebbero nelle organizzazioni, mentre Meyer e Scott hanno posto l'enfasi sull'esistenza di forze sia tecniche sia istituzionali, che agirebbero in modo diverso in diversi tipi di organizzazioni. Zucker infine (un'allieva di Meyer) sottolinea i micro-fondamenti delle istutuzioni, richiamando l'attenzione sulle credenze cognitive che guidano il comportamento: "le conoscenze sociali, una volta istituzionalizzate, esistono come un dato di fatto, come parte della realtà oggettiva, e come tali possono essere trasmesse in modo diretto". (Zucker 1977, pag. 726). |
|
·
Approccio orientato agli oggetti Goldberg (1991), Henderson-Sellers e
Edwards (1995) · Approccio
interazionista Kling e Scacchi (1980, 82), Kling (1987, 89) · Approccio
"Speech-Act" Winograd e Flores (1986), Winograd (1987),
Auramaki et al. (1988, 92) · Approccio "Soft
Systems Methodology" Checkland (1981), Wilson (1984), Checkland e
Scholes (1990), Avison e Wood-Harper (1990) · Approccio "Trade
Unionist" Bjerknes et al. (1987), Hehn (1988),
Bjerknes e Bratteteig (1995) · Approccio
"Professional Work Practice" Mathiassen (1987), Andersen et al. (1990) |
|
|
|
|
13 |
CORRENTE
CRITICA |
Braverman (1974), Clegg e Dunkerley (1977) |
D'ispirazione marxista,
questa corrente sviluppa un'analisi delle organizzazioni dalla prospettiva
dei rapporti di potere/controllo e denuncia il carattere ideologico delle
logiche manageriali. Questi studi sottolineano la dequalificazione del lavoro
generato dal capitalismo industriale, i processi di controllo del personale
legati ai sistemi burocratici, la segmentazione del mercato del lavoro. |
|
|
|
|
|
|
14 |
TEORIE
POSTMODERNE |
Smircich e Calas (1987), Cooper e Burrel(1988),
Alvesson e Deetz (1996) |
Gli scritti postmoderni, che si rifanno largamente ad autori francesi come Barthes, Derrida, Focault, si sono sviluppati con diverse varianti e significati. La stessa espressione "teorie postmoderne" è utilizzata per designare un periodo particolare marcato da importanti cambiamenti organizzativi (le nuove forme organizzative flessibili e/o partecipative) o da un insieme di approcci e nuove prospettive sullo studio delle organizzazioni. In questa seconda accezione, i temi del postmodernismo si focalizzano sulla centralità del discorso e sul potere costitutivo del linguaggio, sulla ricerca di strutture permanenti che si riproducono indipendentemente dagli attori, sulla decodifica di sistemi di credenze e discorsi rispetto a queste strutture, sul declino dei grandi progetti politici, sui legami tra potere e conoscenza. |
|
|
Affermazione delle reti locali 1980 Primo
disco ottico 1981 PC
IBM WordStar,
primo wordprocessor per PC 1982 Nasce
il foglio elettronico Lotus 1-2-3 1983 Nasce
il word processor Word La
CEE dà avvio al programma Esprit per pervenire alla quinta generazione di
computer 1985 Introduzione del sistema operativo
Windows. Il
linguaggio object-oriented C++ diventa uno standard di fatto 1988 Chip
di memoria con capacità nell'ordine di megabit 1989 Nasce
il concetto di "realtà virtuale" 1990
Sviluppo del
linguaggio HTML, del primo web server e del primo browser Creazione
WWW presso il CERN di Ginevra Microsoft
Windows 3.0 fornisce la prima interfaccia grafica in ambiente PC IBM
compatibile. 1991 Calcolatore
parallelo |
Focault (1972, 73), Jencks (1977), Derrida (1978,
80), Bachtin (1981), Lyotard(1984), Rorty(1989), Baudrillard(1988) |
Film: "American Beauty", Mendes (1999) "L'attimo fuggente", Weir (1989) (temi di
potere/conoscenza e ribellione) Romanzo: "Volevo solo dormirle addosso", Lolli
(1998) (tema dell'influsso di linguaggio e cultura aziendale sulla vita
privata) Film: "C'è posta per te”, Ephron (1998), (tema dei
nuovi media/linguaggi nelle relazioni sociali) Romanzo: "Pura
vita", De Carlo (2002) (tema dei nuovi media/linguaggi nelle relazioni
sociali) |
|
Il
“Lenzuolo”, draft rel. 1.2 del 10/2/2003, “Firenze version”. |
||||||||